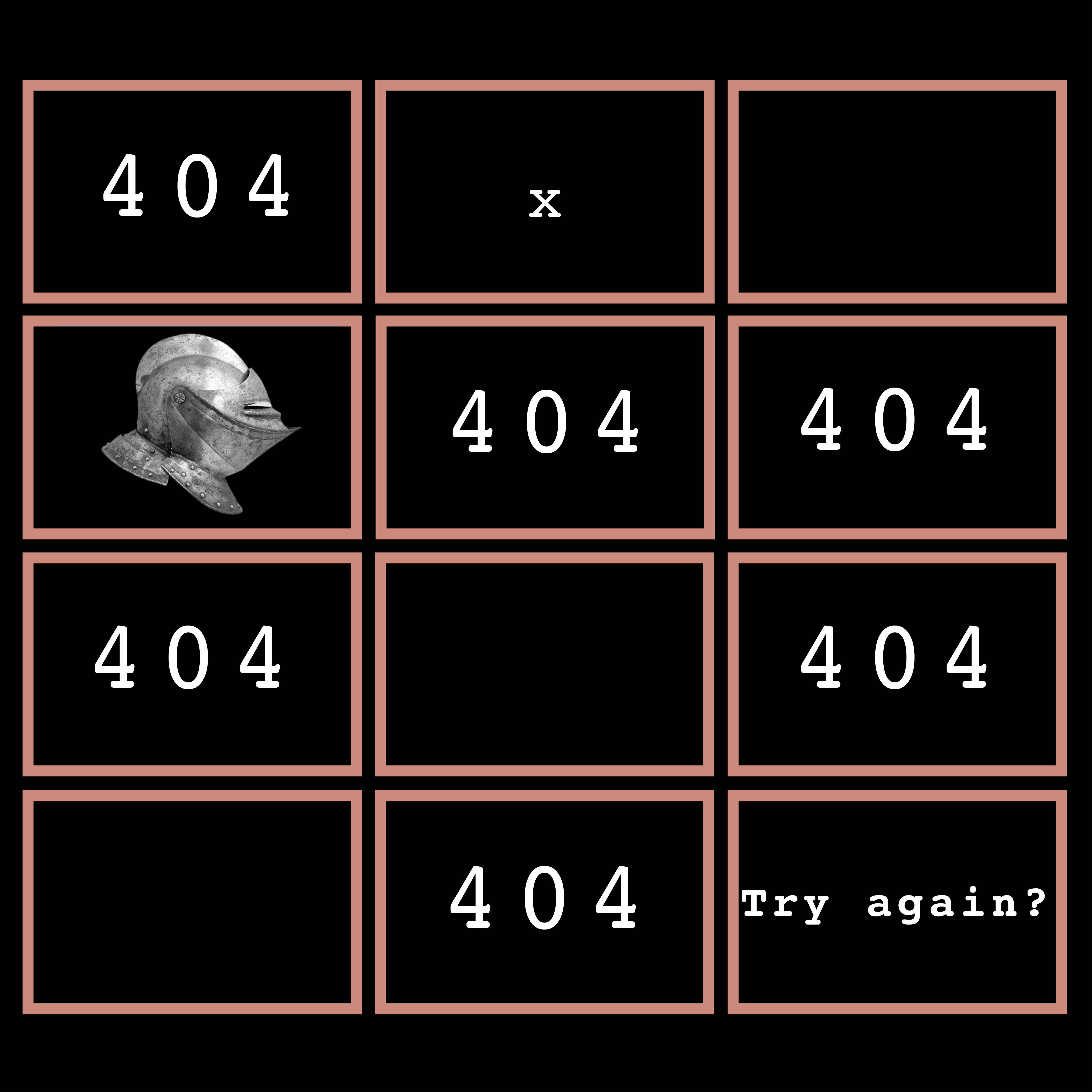Siamo un corpo, o abbiamo un corpo? Questa è la domanda da cui partono i nostri argonauti. Questa nostra fisicità, questa collezione di arti, recettori e vasi sanguigni, è un semplice involucro per quel qualcosa di intangibile che alcuni chiamano anima, oppure una componente fondamentale di quello che siamo? E se il corpo è più di una “tuta spaziale di carne” per il nostro sistema nervoso, non ci si può che chiedere: quando operiamo nell’incorporeità degli spazi digitali, diventiamo qualcosa di fondamentalmente altro?A volte l’impressione è che ci riduciamo a imitazioni della nostra esperienza umana, meri avatar di noi stessi – una legione di cavalieri inesistenti presi dalla futile battaglia del giorno, impegnati senza sosta a raccontare, innanzitutto a noi stessi, tutto quello che siamo e che vogliamo essere.
Fa paura questo mondo nuovo, questa era della dematerializzazione.
Fa paura perché nel racconto continuo di noi stessi esiste il rischio molto reale di dimenticarsi dell’altro e, senza soluzione di continuità, appiattirlo in un avversario usa e getta.
Fa paura perché dà l’impressione di dover imparare di nuovo come si fa ad essere umani, in una modalità completamente diversa.
Fa paura perché non capire le nuove regole d’ingaggio significa fallire anche nel comunicare, e per un operatore artistico come lo sono i nostri argonauti non avere nulla di emotivamente rilevante da dire è come morire.
Ma non c’è solo sterilità, nel mondo dematerializzato. C’è gente come Riccardo Milanesi, che usa le logiche e gli strumenti della transmedialità per saggiare quali siano i confini del raccontare storie; c’è Martina Dego, protagonista della sua serie L’altra, personaggio dichiaratamente fittizio ma che è riuscita a catturare il tempo e l’attenzione di un pubblico fedele ed empatico.
C’è una verità fondamentale: per le persone che hanno seguito Martina durante la settimana in cui si è dipanata la sua storia, la sua mancanza di corpo era un fattore completamente irrilevante. Di più: i gruppi di persone che si sono creati intorno alla sua vicenda, le comunità e le interazioni, erano incontrovertibilmente reali.
Da questo punto di vista, la domanda del “cosa siamo?” diventa molto meno rilevante di:
“Chi riusciamo a toccare? E in che modo?”
E se l’era della dematerializzazione continua a far paura, forse anche le opportunità che offre non sono da ignorare. Forse anche le sue meccaniche meno sane possono essere hackerate, imbrigliate, usate per toccare altri esseri umani. Forse la fake identity che i nostri argonauti hanno il compito di creare dev’essere come una pescata da un mazzo di tarocchi: una suggestione, una spinta, uno specchio segreto a cui attirare lo spettatore e dargli lo spazio per smettere di raccontarsi e guardarsi dentro. Il problema è dunque riuscire a creare il giusto contenitore, un percorso che possa portare lo spettatore al luogo d’incontro con se stesso e con l’altro.
Come una mappa.
Come un oracolo.
Giovanni Pigliacelli